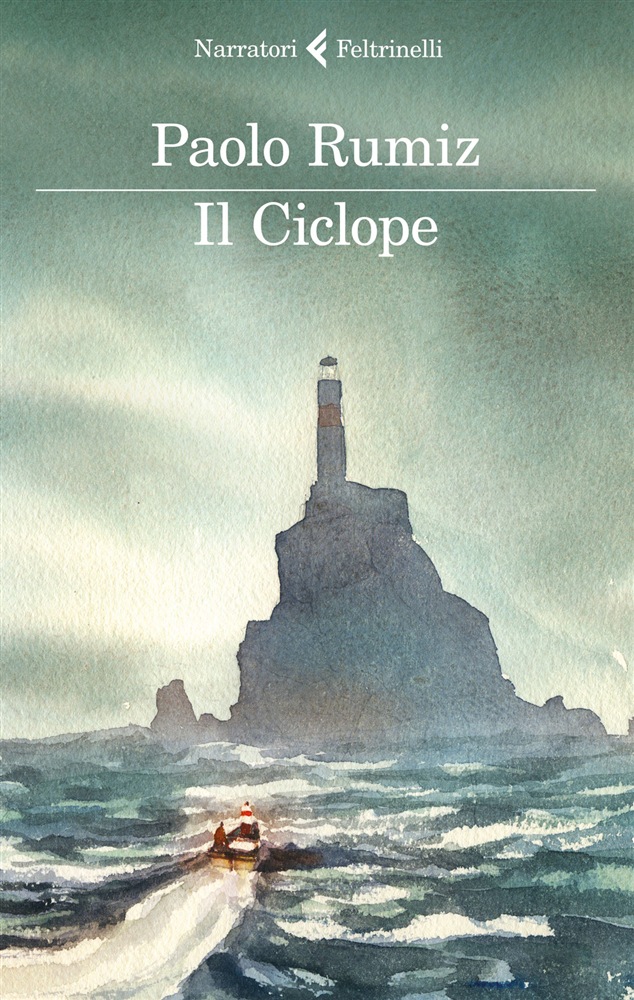Abbiamo scoperto praticamente insieme questo autore, Paolo Rumiz, giornalista corrispondente in mille luoghi della terra, dallo stile ruvido, poetico e appassionante.
Impossibile non rimanerne ammaliati tanto che siamo già alla caccia di altre sue opere (io, Silvia, ne ho già scovate altre quattro: Ombre sulla corrente, Morimondo, A Piedi e Maschere per un massacro-Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia) e ci sentiamo legate a lui, a doppio filo, perché questo libro che ci apprestiamo a recensire, Il Ciclope, racconta dell’esperienza lavorativa e umana di Rumiz come guardiano di un faro e per noi il faro, con tutto ciò che ne concerne, è qualcosa di magico e personale, legato alla nostra saga, La Memoria del tempo.
Difficile riuscire ad andare per ordine, del resto Rumiz stesso non lo fa, vi avvisiamo, tuttavia, che da qui in avanti saranno presenti diversi SPOILER, anche se, è bene ribadirlo, questo libro non è un artifizio letterario, narra fatti veri.
E’ l’impressione personale dell’autore sulla sua esperienza di vita in un faro. Un’esperienza che lo porta a rivalutare tutto quanto, persino il rapporto che abbiamo con la tecnologia ma ci arriveremo.
La prima cosa che ci viene in mente, benché non sia appunto la prima di cui parla il giornalista, è il suo amore autentico, sincero, pulito per l’Italia e la civiltà mediterranea, un amore pulito perché non vi è ombra di razzismo o superiorità morale/intellettuale, ma solo il sacrosanto orgoglio per la nostra civiltà sempre troppo bistrattata, in primis da noi stessi.
Lo stesso faro o meglio i nostri fari sono il simbolo di questo nostro dannato vizio di sputarci addosso: sono i più belli e maestosi dell’intero creato ma andiamo a venerare quelli del nord, autentiche brutte copie dei nostri gioielli.
“A chi, come me, è nato in Adriatico, non la darete a intendere che i fari più belli d’Europa stanno in Bretagna o Cornovaglia. Sappiatelo, voi che amate il mare e vi fate infinocchiare dalle foto che glorificano torri oceaniche assediate dai marosi. Il Mediterraneo non è da meno”
Siamo proprio degli imbecilli.
Seconda cosa, non meno importante della prima: il suo amore per la Natura anche negli aspetti più terribili. Tuona inviperito contro l’industria ittica che ha portato a svuotare i mari e a stravolgere i delicati equilibri dell’ecosistema dell’isola. I gabbiani, incapaci di trovare sostentamento nel pesce, razziato da avidi esseri umani che ascoltano solo la voce del denaro, diventano dei sistematici predatori sulla terra. E citiamo nuovamente: “in trent’anni il Mediterraneo si è svuotato del settanta per cento della sua ricchezza ittica. Me l’aveva svelato Tamara Vucetic, biologa marina croata, durante un viaggio in Dalmazia” Ha orrore e prova pietà per questa umanità piena di paure che non hanno alcun senso, a cui dà l’etichetta di “paranoia”, ma che è incapace di ascoltare il grido di una natura che sta boccheggiando e dice: “basta”.
E a proposito di paure insensate, Rumiz dice che stando isolato dal mondo, a stretto contatto con la natura e con le persone che lavorano così ai limiti, si è sentito vicino come non mai a tutto, ha percepito letteralmente il dolore e lo smarrimento del mondo, la guerra in Siria, la fuga disperata dei profughi, il nostro paese in crisi, tutto quanto.
Lo stare al contatto con chi fa lavori così duri, come il farista, che deve occuparsi di ogni cosa, da solo o con la sua famiglia, ha amplificato i sensi e le percezioni di Rumiz, gli ha fatto rallentare il ritmo, ha migliorato la sua scrittura, parole sue, rendendola più diretta, autentica, meno colma di orpelli.
Ha visto il tempo dilatarsi tanto che le tre settimane gli sono parse tre mesi e lo hanno costretto a scrivere pagine e pagine di fogli, dove ha temuto di non poter scrivere tutto.
E ha ricordato come il Mediterraneo sia il mare nostrum non per un qualche senso di proprietà o superiorità, ma per senso di appartenenza e fratellanza, un mare che accomuna popoli diversi, non così diversi, in mezzo ai quali, nei fari, si parla una lingua universale, una sorta di nuovo esperanto, dove si mescolano dialetti e lingue e dove tutti si capiscono.
Teme che questo mare nostrum si sia perso perché troppe persone, anche nel web, soprattutto nel web, hanno perso la capacità di vedere e percepire le cose complesse, si divide tutto in due fazioni, Nord/Sud, noi/loro, quando non è proprio così. E’ molto più di così.
“Appartengo dunque allo stesso modo a Salonicco e a Beirut, a Orano e a Formentera. Alla mia gente, le miserabili definizioni nazionali hanno portato sempre e solo sventura. Per questo noi sentiamo il mare come la casa di tutti, e intendiamo nel modo giusto la definizione “Mare Nostrum”. Che non significa “Il mare di nostra proprietà”, ma “Il mare di tutti coloro che lo abitano e, a prescindere dalla lingua, sono affratellati da un sentire comune…
Penso: cos’è rimasto del mare di mezzo? Quasi nulla. Già il fatto che si parli di due rive contrapposte dice che la battaglia è persa. Perché due rive? Perché abbiamo accettato questa semplificazione bipolare? La civiltà del web ignora la complessità.”
Ecco noi ci ripeteremo, ma ce la facciamo ad uscire da questo meccanismo perverso che ci deve far dividere tutto in due fazioni?
Vale per ogni cosa.
Critichi un grillino, sei renziano; critichi Renzi, sei grillino o berlusconiano; vuoi salvare i profughi, sei a favore dell’immigrazione selvaggia; vuoi dei controlli, sei un razzista.
Basta, veramente, basta. Aprite il cervello, siamo esseri umani, non siamo bianchi o neri, siamo bianchi e neri, siamo a sfumature, dov’è davvero finito il mare di mezzo?
Ridatecelo, ridateci la poesia di Salvatores che chiedeva che il Mediterraneo tornasse ad essere ciò che è e non un fossato.
Una parte considerevole del libro è dedicata al cibo. E, onestamente parlando, mentre leggevamo quelle pagine ci è venuta una fame spaventosa. Il cibo come fonte di sostentamento da centellinare, perché gli approvvigionamenti in un’isola non sono facili da ottenere, ma anche come ponte di comunicazione tra le persone.
Tutto è cucinato con la massima cura e semplicità, con ingredienti del posto, freschi, genuini, autentici.
Rumiz ha offerto alcuni piatti tipici del nord, in particolare molti risotti, di cui sembra essere ghiotto e nel contempo ha imparato a fare il pesce come un vero farista, ogni tipo di pesce pescato lì, nei pressi del faro, in cima al quale si mette a leggere e a guardare il mondo.
All’inizio del libro l’autore non dà molte coordinate sull’ubicazione dell’isola, solo velati suggerimenti e un’esortazione a tenerla nascosta nel caso in cui il lettore riuscisse a individuarla con tanto di minaccia di maledizione. In realtà, maledizione a parte, diviene subito comprensibile il perché di questa reticenza. La sua esperienza in quel particolare faro, si allarga e ben presto diventa chiaro che ciò che racconta in quell’angolo di mondo è qualcosa di universale, qualcosa che riguarda non quel punto precisato. Ciò che sta raccontando, oltre alla sua vita in un faro, in realtà è il rapporto tra umanità e natura o meglio, tra umanità e antichi Dei di cui è ancora possibile ascoltare la voce se si è abbastanza ricettivi.
Recensione redatta da Silvia Azzaroli e Simona Ingrassia.